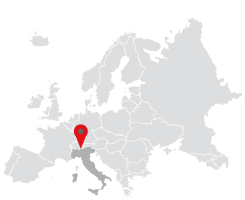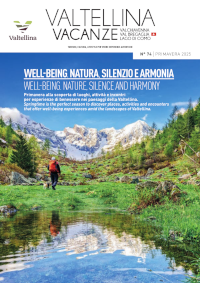di Nicola Rizzi
Un racconto personale rievoca l’antica attività dell’uccellagione, un tempo praticata da alcune famiglie sulle sponde della Valchiavenna.
“Questi gradini li avrò segnati giusto un paio di volte, occhio che si scivola”. Pietro parla con ironia e senza fermarsi un attimo, spalle larghe da toro, 80 anni e una andatura che mi costringe agli straordinari, mentre superiamo alcune rocce squadrate in gradini. Modellate dal passaggio di chissà quanti pastori, contadini, cervi e creature del bosco, ne lasciano intravedere le storie.
Proseguiamo attraverso il faggeto sopra Uschione, direzione Val Bregaglia, accolti da centinaia di vecchi massi che sbucano tra gli alberi, coperti da un bel muschio riccio. Pietre sagge e barbute, custodi della foresta. Si percepisce un tempo sospeso, fermo come i rami spessi dei castagni, ondeggia quel che basta per raccontare un passato che sa di leggende e popoli di fate. Tutto è immobile, ma allo stesso momento tutto si muove. Noi con lui, insieme ma separati. La storia a cui penso, superando quei gradini scivolosi, non è certo antica né leggendaria, ma è avvenuta proprio lì. Sentita decine di volte da piccolo, è ormai un panorama nella mente, ed io mi guardo intorno calibrando l’immaginazione della mia infanzia con la realtà che mi circonda.
Era uno dei racconti che preferivo da bambino, di quelli perfetti per passare il tempo in macchina, ed infatti cavallo di battaglia durante le lunghe ore di code passate in superstrada, mentre si tornava in città dopo il weekend. Parla di boschi, di papà da piccolo, del nonno che non ho mai conosciuto e della vita nel dopoguerra con quella responsabilità che cresceva rapida nei giovani cuori di montagna.
Oggi, 30 anni dopo, la risalgo piano questa salita tesa e scivolosa, cercando quel che resta di un’antica torre da caccia, ma ripenso a quel giorno quando papà filava verso valle. Non mi capacito di come ci riuscisse! Schivo lentamente buche e foglie bagnate, ma me lo vedo bene scendere veloce sopra il muschio umido, saltare sassi e guadare ruscelli con le sue gambette, in fuga dallo sguardo severo del nonno, con il cuore in gola e una gabbietta per uccellini in mano. La gabbietta è sempre stato il particolare che mi prendeva di più della storia, tenuta in mano chissà perché e chissà come. Dentro un fanello e un cardellino, sballottate esche che con il loro canto avevano attirato altri fanelli e altri cardellini e tordi, nel cerchio della caccia senza fucile che quel giorno diventò fiaba. Almeno per me, nei miei ricordi di allora ed oggi, mentre Pietro avanza a marce forzate. “Eccolo, siamo arrivati”. Lui non suda, non sbuffa, non sbaglia una curva. Ha parlato tutto il tempo. Io ho grugnito un assenso, sudato litri di vizi della città e bevuto già tutta l’acqua. “Eccolo” dovrebbe essere un sentiero, mentre vedo solo vegetazione più fitta. Sposta con le bacchette i cespugli di rovi che hanno ricoperto e nascosto un passaggio dimenticato, subito al di là di un filare di cinque arbusti di amareni secchi e arrotolati. Mi ci soffermo qualche secondo prima di seguirlo nella selva, perché mi sembra che l’unico modo per cui possano avere quella forma buffa, è per via di una mano gigante che li abbia torti come fusilli. Superata la fantasia e il tratto da giungla e macete, in mezzo agli incroci di betulle e larici cresciuti alti a braccia in sù, intravedo una torretta diroccata. Il casello, chiamato in gergo, è più piccolo di come lo immaginassi, naturalmente. Tutto verde e attraversato dalla natura che ne ha quasi preso il pieno possesso, ci ho messo un pò ad individuarlo, così mimetizzato. Pietro no, beccato subito. Dentro profuma di funghi, legno bagnato e ricordi, la struttura a più piani è collassata da tempo, ma riconosco il camino e quello che doveva essere il finestrone con le feritoie che, secondo il racconto, erano quelle da dietro le quali si tenevano d’occhio gli stormi che andavano a posarsi sui rami. Me li immagino lì allora, papà con il nonno e il cacciatore, ben nascosti, che parlano a gesti per non spaventare tutti quei tordi che si stanno posando proprio dove dovevano posarsi. Erano tanti, tantissimi quel giorno, per la pesca miracolosa di una caccia senza spari, fatta di attesa e silenzio, di fortuna e preghiere per indovinare il momento perfetto. Quello in cui si lanciano fischi e grida, lo stormo spaventato si alza in volo, ma le reti invisibili tra gli alberi ne fermano la fuga e li catturano a centinaia.
Immagino sul volto degli adulti la gioia per la buona sorte e papà pronto, prontissimo con il suo spauracchio in mano, nient’altro che una vite fissata in un tassello di legno. La giri e fa il verso del falco, un oggetto semplicissimo per un’azione altrettanto semplice ma delicata. A lui quindi l’onore e la responsabilità più grande. Un piccolo fischio che avrebbe dato il via alle danze, simulando la calata di un predatore e spinto tutto quel ben di Dio di uccellini in rete. Nove anni e il desiderio di essere l’uomo partita, come un goal in coppa del mondo, il prestigio di fare la differenza tra i grandi.
Ma invece..
Questa è la storia della fretta, di quella volta che ha fischiato troppo presto e i tordi son volati via tutti, tradito dall’emozione per l’emozione. Il nonno furibondo e quindi la fuga con la gabbietta in mano, forse per non essere solo nella vergogna, e la gloria mancata di un soffio; nove anni e correre giù dalla montagna fino a Chiavenna, qualche km per farsi coraggio fino a casa e la tenerezza di uno storia semplice che ha attraversato le generazioni fino a me. Un gradino per volta, dalla montagna fino in città, senza fretta. Con calma.
IL ROCCOLO
I primi roccoli risalgono addirittura al Trecento e furono realizzati dai frati bergamaschi. Venivano usati principalmente per la cattura degli uccelli con reti, pratica che fu vietata nel 1968. In Valchiavenna sono presenti varie testimonianze di questa antica attività. L’impianto del roccolo si compone di due elementi distinti: la torre (detta anche “casello”) e la parte vegetale circostante, chiamato “tondo”. Il funzionamento dell’impianto era semplice: con dei richiami (di solito erano degli uccelli chiusi in gabbia) venivano attirate le prede all’interno del tondo. Al momento opportuno, veniva lanciato un bastone - “batarel” - ornato di rami di salice che simulava il volo del falco. Gli uccellini si spostavano verso il filare degli alberi che componeva il “tondo” e rimanevano impigliati nelle reti tese lungo tutto il perimetro. Queste catture venivano rivendute vive nei mercati e nelle fiere di tutta la regione.